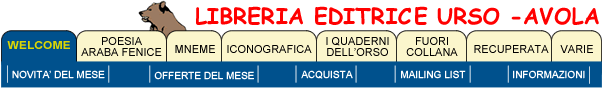
Giorgio Morale |
Carissimi,
ricordando la discussione sulla scrittura del dicembre di 2 anni fa nella libreria di Ciccio, e leggendo dalla newsletter di Ciccio che anche quest'anno ci sara' una discussione su un tema analogo, mi fa piacere partecipare anch'io, pur se virtualmente, all'incontro, inviandovi alcune riflesioni sul tema sviluppate in occasione di un'intervista che e' uscita oggi, che potete leggere cliccando qui: http://sulromanzo.blogspot.com/2009/12/intervista-giorgio-morale.html Insomma, come diceva una canzone di tanti anni fa, sempre le stesse cose viste sotto mille angoli diversi.
Ecco l'Intervista a Giorgio Morale Buongiorno, vorrei iniziare chiedendole a quale eta' si e' avvicinato alla scrittura e se e' stato o meno un caso fortuito. Ho cominciato a scrivere poco dopo aver imparato, anche se vedo la scrittura come l’esito di una lunga preparazione: all’inizio ci sono le giornate lunghe dell’infanzia e un appuntamento che si ripete, l’attesa di una voce altra da me che racconta; poi la voce altra nasce da dentro di me e sono io che l’alimento, fino a che diventa scrittura.
Se consideriamo come estremi l’istinto creativo e la razionalita' consapevole, lei collocherebbe il suo modo di produrre scrittura a quale distanza dai due?
La scrittura, come la condizione umana, e' plurale. E mi pare che non solo ogni scrittore, ma anche ogni libro, per ogni scrittore, sia diverso dall’altro, che ognuno abbia una storia diversa, per genesi e modalita' di composizione.
Penso che sia l’istinto creativo che la razionalita' consapevole siano delle astrazioni. Perche' io scriva, il mio punto di partenza e' un dato di verita'; un forte vissuto. Puo' essere un sentimento, un’immagine o una storia, un’esperienza significativa: se ne scrivo e' perche' diventa un tema che mi coinvolge totalmente e finisce per abitarmi. Allora tutta la realta' riceve luce da quel “tema”, tutto quello che vivo viene assunto in esso. E intanto che cresce, il tema determina sempre piu' chiaramente uno stato d’animo, mentre fili diversi si organizzano in una storia: mi metto a scrivere quando non posso farne a meno, quando le parole premono per venire fuori, avendo trovato la forma che le dica. e' lo stesso senso di necessita' che cerco come lettore. D’altra parte, come diceva Hafez, “A quel verbo m’inchino che grande una fiamma seconda, / non a quelle parole che gettano acqua sul fuoco”.
Poi arriva il momento di organizzare il materiale in una struttura, decidere come far cominciare e finire il libro, rivedere il linguaggio, e allora occorre anche capacita' tecnica e conoscenza della lingua e della letteratura, della sua storia e dei suoi strumenti. Non so pero' se si possa parlare di “razionalita' consapevole”, in questa attivita' razionalita' e sensibilita' non sono mai disgiunte, anzi la sensibilita' e l’immaginazione sono una componente del mestiere e strettamente impastate con la tecnica, le due cose si sostengono a vicenda. Mi viene in mente quello che dice Franco Loi del suo far poesia: vado in giro, guardo, sento, parlo fra me e me e mi accorgo che penso in endecasillabi.
Moravia, cascasse il mondo, era solito scrivere tutte le mattine, come descriverebbe invece il suo stile? Ha un metodo rigido da rispettare o attende nel caos della vita un’ispirazione? Ce ne parli.
Non vivo dell’attivita' di scrittore, percio' tutte le mattine sono al lavoro e non ho le 4 o 5 o 6 ore al giorno di scrittura, come dichiarano alcuni scrittori. Non so come sarebbe, se anch’io potessi permettermelo, a pensarci oggi le 6 ore quotidiane mi sembrano di una meccanicita' che non s’addice alla mia idea e pratica di scrittura. Ma ognuno impara qualcosa dalla condizione che si trova a vivere e teorizza a partire da essa. Il mio metodo oggi e' dettato dall’urgenza, dal bisogno di restituire un’esperienza della cui trasmissione mi reputo responsabile. Quando e' necessario scrivo per strada, in piedi, sul tram, anche su un foglio per appunti o su un biglietto, e tutto sommato mi pare una buona cosa, che la scrittura prenda aria, che nasca all’aria aperta. Sono appunti preziosi, che nel testo finale costituiranno dei validi dati di realta'. Al momento della scrittura definitiva pero' occorre creare le condizioni affinche' quanto maturato possa essere trasferito sulla pagina, e verificare che la trascrizione sia stata fedele, e questo richiede avere un buon tempo davanti a me. A lavoro finito, leggo il testo nelle situazioni piu' diverse, anche le piu' disturbanti. Se il testo regge alla lettura in queste condizioni, e' accettabile.
Allo stesso modo non mi sono mai preoccupato di quanto scrivere, non mi pongo l’obiettivo di un numero di pagine da produrre quotidianamente ne' di raggiungere un certo numero di pagine per considerare il libro concluso.
Di che cosa non puo' fare a meno mentre si accinge alla scrittura? Ha qualche curiosita' o aneddoto da raccontarci a riguardo?
Io non ho bisogno di molto, non sono e non desidero essere lo “scrittore”, la “torre d’avorio” e lo status di “professionista” non fanno per me, anzi mi iscrivo volentieri tra i dilettanti. Sono una persona che vive e lavora e che, quando ha qualcosa da dire e puo' dirlo, scrive: perche' scrivendo ho la possibilita' di dire e di fare piu' mia la mia esperienza della vita e del mondo, completo me stesso e ho qualcosa da dare agli altri. Certo, c’e' il lavoro, ci sono gli impegni quotidiani, mentre scrivere, soprattutto in alcune fasi, come dicevo prima, richiede raccoglimento e tempi lunghi: e mi piace scrivere in un luogo in cui mi senta a mio agio, in silenzio. Al contempo mi va bene il primum vivere, amo una scrittura che nasca dalla vita e dall’esperienza, che sia strettamente intrecciata con esse e che percio' finisca con l’essere essa stessa un’esperienza importante; e mi va bene anche l’attesa: dover rimandare il momento della scrittura accresce il desiderio di scrivere, mentre il tema si chiarisce, le scene si compongono e le frasi si formano.
Percio' per scrivere mi basta carta e penna. Scrivere con la penna mi da' la sensazione fisica di un travaso da me alla pagina e mi sembra che mi dia maggiormente la possibilita' di seguire il corso dell’immaginazione, dei pensieri e dei sentimenti nel loro formarsi: per me e' il modo di scrivere piu' flessibile che esista. Solo in un secondo tempo trascrivo in word. L’uso del computer permette di verificare immediatamente soluzioni diverse, montare e smontare dei brani e intrecciarli variamente; permette anche di garantire una maggiore uniformita' di tono e di lessico, nonche' di provare che effetto fa vedere la scrittura in un formato simile a quello “stampato”. Se ho bisogno pero' di schierare davanti a me pagine e capitoli, per avere una visione contemporanea di parti diverse di un testo, questo il computer non lo permette e torna di nuovo utile la carta.
Wilde si inchino' di fronte alla tomba di Keats a Roma, Marinetti desiderava “sputare” sull’altare dell’arte, qual e' il suo rapporto con i grandi scrittori del passato? e' cambiata nel tempo tale relazione?
La lettura di altri scrittori e' imprescindibile, se scrivo e' perche' ho letto e amato la lettura e ho visto a ogni lettura un accrescimento della mia esperienza. Alterno sempre letture di scrittori del passato e di scrittori d’oggi. Gli scrittori d’oggi comunicano il sentire e il ritmo del presente, ma veramente presente e' cio' che e' sempre presente, altrimenti la scrittura e' solo cronaca, cosa che passa e invecchia presto. Quello che piu' conta e' la qualita' e lo spessore della scrittura: occorre che io leggendo ricavi non mere informazioni, ma una moltiplicazione di senso e di possibilita' che mi riguardi da vicino, indipendentemente dal fatto che l’opera sia del passato o del presente.
Oggi oltre ai nostri classici ci sono da conoscere anche le opere di letterature non occidentali, in particolare sono molto ricche e in gran parte da scoprire per noi le letterature araba, indiana, giapponese e cinese.
L’avvento delle nuove tecnologie ha mutato i vecchi schemi di confronto fra centro e periferia, nonostante cio' esistono ancora luoghi italiani dove la letteratura e gli scrittori si concentrano? Un tempo c’erano Firenze o Venezia, Roma o Torino, qual e' la sua idea in merito?
Non ho idee particolari al riguardo. Io ho cominciato a scrivere ad Avola e immagino che, se non fossi venuto a Milano, avrei continuato a scrivere lo stesso, anche se certamente cose diverse da quelle che poi ho scritto. e' vero che la citta' permette di avere maggiori contatti; senza che cio' garantisca pero' di avere accesso all’industria culturale. I miei contatti comunque si limitano a un paio di amici, che sono preziosi per la vita prima che per lo scambio letterario. Allo stesso tempo l’incidenza di Internet nel collegare a prescindere dalla localizzazione geografica mi pare crescente, anche se non ancora determinante.
Scrivere le ha migliorato o peggiorato il percorso di vita? In altre parole, crede che la letteratura le abbia fornito strumenti migliori per portare in atto i suoi desideri?
Non posso dirlo, perche' non so come sarebbe stata la mia vita senza scrittura, dato che, anche se poco, ho sempre scritto. Per me scrivere e' un’attivita' del tutto gratuita, ma costitutiva dell’identita' personale. Lo diceva anche Marx: “Il Milton produsse il Paradiso perduto per lo stesso motivo per cui un baco da seta produce seta. Era una manifestazione della sua natura”. Il contatto con il mercato viene dopo, anche se, vivendo il mio tempo e leggendo cio' che si scrive e si pubblica oggi, non posso non esserne in qualche modo condizionato. Posso dire che scrivere mi pare uno spazio di liberta' personale per tutti, uno spazio di riflessione e di dialogo intimo e meditato con se stessi e con gli altri. Anche nei tempi piu' bui, quando non puo' che dire la disperazione ed e' l’unica forma di resistenza possibile, la scrittura mi pare contenere un germe di fiducia nell’uomo e di speranza nel futuro.
La ringrazio e buona scrittura.
Grazie a lei.
Giorgio Morale e' nato ad Avola (Siracusa) nel 1954 e dal 1972 risiede a Milano, dove si e' laureato in Filosofia e ha lavorato nel giornalismo, nel teatro e nella promozione culturale. Dal 1989 insegna Lettere negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Nel 2005 ha esordito nella narrativa con “Paulu Piulu” (Manni editori). Sempre per Manni, nel 2009 ha pubblicato “Acasadidio“. Scrive su “Bottega di Lettura”. Fa parte del comitato di lettura della casa editrice on line vibrisselibri. e' redattore del litblog La poesia e lo spirito. |
Per continuare una discussione È bello, arrivando ad Avola per una brevissima visita natalizia, essere accolti con l’invito a una discussione in libreria da Ciccio Urso, la sera del 29 dicembre 2007, a discutere su Perché si legge perché si scrive. E mentre intorno impazza la festa, far festa in mezzo ai libri e rivedere alcuni e conoscere altri: Ciccio, Michele, Liliana, Paolo, Corrado, Leonardo, Enzo, Salvatore, Benito, Nino e altri che in questo momento mi sfuggono. E siccome alle cose belle si vorrebbe dare un proseguimento, e da amanti dei libri le stesse domande ce le faremo sempre, ecco che faccio seguito a quel paio d’ore di discussione con alcune domande e con una mia personale testimonianza sulla lettura.
Per Nino: tu dici che la scrittura è, in accordo con una visione freudiana, pulsione. D’accordo, però: è solo questo? Nient’altro? La psicanalisi ha superato i 100 anni, allora perché non chiamare in causa anche altri fondamenti come l’inconscio collettivo di Jung o la volontà di potenza di Adler o il trauma della nascita di Ferenczi o le nuove ricerche di Hillman? O quello che, al di fuori dell’ambito psicanalitico, hanno detto filosofi, scrittori e poeti? Per Enzo e Leonardo: per voi la scrittura è terapia, d’accordo, e salva la vita. Il problema che pongo è: salva la vita anche una medicina, la vicinanza di una pianta o di un animale, una carezza, la benevolenza dell’ambiente… ma la scrittura ha un suo specifico oppure no? E se ne ha uno, qual è? Per Benito e Salvatore: si scrive per se stessi, voi dite, e chi scrive è il primo lettore di se stesso. Ma qual è il motivo per cui io come lettore non leggo in continuazione solo me stesso ma mi nutro della scrittura di un altro e ne faccio sangue del mio sangue? Perché, oltre l’individuo, c’è l’opera che avanza? A quali condizioni questo si realizza e perché? Io e la lettura: la libertà è un libro aperto Il mio angolo, la lampada, il libro. Disteso in perfetta immobilità, il corpo raccoglie la leggera brezza, inavvertita in posizione eretta. La radio rimane sullo sfondo, in attesa che qualcosa desti un picco d’attenzione e la riporti in primo piano. Presto la musica diventa d’intralcio alla lettura. Parole e note si contendono l’attenzione. Le parole, come la musica, vanno prese goccia a goccia, nota per nota. Tutta la stanza, le pareti, i mobili sono raccolti e concentrano il loro essere nel favorire la mia lettura. Da certi libri mi sento scoperto. Il libro parla – a me; sa – di me – cose ch’io ignoro. Avverto come un ronzio: la mia voce e un’altra. Come l’arte, non cerco la lettura, la lascio accadere. È come respirare, mangiare, bere, dormire, defecare, orinare: così è per me leggere. Mangiare ha i suoi orari, defecare i suoi luoghi, ma di respirare non smettiamo mai. Ugualmente io di leggere. Non perché legga in continuazione, ma perché la lettura agisce in continuazione. Il blank di ciò che leggo si integra con la vita quotidiana e diventa un elemento del vivere: aria, nutrimento, anima. Leggo sul divano, a letto, in coda al supermercato e alla posta, sul tram e in treno. E soffro l’astinenza come un digiuno forzato. Poi mi ricordo di Sbarbaro: Non avverto nessuna parentela con chi in treno, invece d’aver l’occhio al paesaggio, non importa se visto le mille volte, lo tiene su un libro, sia pure la Commedia. Ho grande stima di Sbarbaro, allora chiudo il libro – e guardo: il mondo, le persone. Alberi, erbe, qualche cosa. Arpino diceva che scriveva in piedi. Bello. Bello anche leggere in piedi. Anche i libri, come i pensieri, hanno bisogno d’aria. Alcuni libri li leggo così: sfoglio e leggo qualche frase. Ad esempio: * * *
Ho letto per la prima volta l’Odissea sul terrazzo di casa. Il mare, in lontananza. Il mare visto e il Il mio amico Orazio riuscì a suscitare in me un altro interesse: la filosofia. Ogni giorno, nell’ora stabilita per le mie uscite, appena varcata la soglia di casa di Orazio, per me il mondo si faceva meno opprimente, la solitudine svaniva, noia e malinconia perdevano ogni connotazione negativa, anzi esaltavano progetti: di opere e azioni, fughe e rivoluzioni. Ricordo la Germania dell’emigrazione, la monotonia dei pasti consumati in silenzio, l’eternità dei faccia a faccia che contano i bocconi. Poi guardavo fuori. Dai vetri orlati di vapore, sempre lo stesso tratto di città. La libertà era un libro aperto. Ricordo quelle sere d’estate in cui il mondo è in attesa di qualcosa che non arriva e s’invoca la cessazione di tutto. Mi affacciavo alla finestra e guardavo. Tante luci accese, tante ferite nel buio. Era come essere in un sommergibile o in una tenda a ossigeno. Né vivi né morti, sospesi fra due regni, come gli eroi greci morti senza sepoltura. Come dice Paula Fox, la libertà era una biblioteca pubblica. Ricordo i primi tempi a Milano. Leggevo al buio, sul tram, per strada. Leggevo male, perdevo il segno, ricominciavo daccapo. Famelico. * * * Ripenso a tanti libri letti di corsa, pensando: Ci sarà una seconda volta. Eppure, quando? Leggo da quando avevo cinque anni, ma ci sono tantissime cose che non ho letto e tante cose che ho dimenticato. A volte mi sembra che dovrei ricominciare a leggere tutto daccapo. Come ricominciare la storia del mondo, a partire proprio da Assiri e Babilonesi. Mi vedo leggere a un tavolo, mentre cade la pioggia. L’imposta del balcone è aperta. Posso guardare fuori: un pezzo di cielo e la casa di fronte. Leggo leggo e quando mi fermo avverto brividi di freddo. Mi aggiusto sulla sedia e muovendomi faccio traballare il tavolo. Godo di questa posizione abituale e mi compiaccio di prolungarla. Il letto è sfatto, ma non in disordine, si affonda quanto basta per indicare il mio passaggio. Davanti a me stanno pile di libri. Leggo leggo e di frase in frase aspetto una rivelazione. |
Un poeta canta meglio
quando è calpestato Arriva la primavera, la natura si risveglia, il sangue circola più veloce nelle vene e il poeta canta l’“antica festa crudele”. “Molto
mi piace la lieta stagione di primavera… A cantare così è il poeta-feudatario Bertran de Born. Tu Fu, il poeta-saggio, canta diversamente. “Non comprendiamo
perché mai l’imperatore, Oppure: “Laggiù,
ho sentito, si è abbattuta la catastrofe E altrove: “Nessun
suono di battaglia nei campi incolti sotto un
cielo terso * * * Il desiderio di Tu Fu è un altro: “Di nuovo mi tormenta senza
tregua La natura, sempre potente, in lui appare spesso impastata di fango e sangue. “Monti coperti di neve, fiumi
gelati, campi spazzati dal vento Anche la bella stagione, quando arriva, non porta con sé l’attesa gioia di vivere: “Racconta storie non vere il
canto gioioso degli uccelli… Il Poeta dà voce alle domande della gente comune: “I funzionari del distretto
rapidi esigono le imposte “E se anche tu, signore, volessi
interrogarci “Signore, hai visto sopra il
Lago Verde “Da quando ho inviato l’ultima
lettera a casa “Di quante vite si è compiuto
il destino? Questa è la domanda della nuova sposa: “Di sera le nozze, all’alba
l’addio Questa è quella della bella donna: “I miei fratelli andarono al
massacro E questa quella del padre che ricorda il figlio bambino: “E’strano come in tua
assenza le stagioni si affrettino Quando parla d’altri, Tu Fu parla di sé; e sa parlare di sé come se parlasse d’altri. * * * L’interrogazione è il gesto linguistico più ricorrente in Tu Fu ed esprime la meraviglia infinita di quest’uomo che tanto ha vissuto di fronte a quanto tra gli uomini possa succedere. Ci parla di un’età di disordine e incostanza. Ma quale epoca non è di disordine e incostanza? “Disordine e incostanza in che conto metterli?”. “E alzandoci in volo senza accettare regole a che cosa miriamo?”. “Chi vuole in tempi così densi
di pericoli “Nel fluire della vita che
score inarrestabile “Sono triste, perché sono triste?”. “Come posso per un giorno intero tener dietro ai miei mesti pensieri?”. “Chi dopo tanto disordine vorrà tornare indietro?”. Sono domande che, senza essere retoriche, non esigono risposta. Il silenzio le accoglie e le amplifica. Benché sia fedele all’ordine costituito e abbia vissuto anche vicino al potere, Tu Fu sa, con Confucio, che, se c’è disordine e incostanza, il potere ne è il primo responsabile. Quando nell’uomo di potere prevale l’interesse personale, si crea una divaricazione insanabile tra il potere e la gente, l’esecuzione formale di un dovere e il rispetto della natura umana, il palazzo e l’umile dimora, la ragion di Stato e la sfera dell’individuo e della famiglia, la volontà di potenza e le regole del vivere civile, la guerra e la pace. Alla fine a essere questionata è la natura umana. I suoi limiti invalicabili. La guerra appare una legge della storia. “La morte non m’ha voluto “C’è da chiedersi
dove mai si possa “Io triste penso nella dolce
notte “Quando domina il principio
maschile,
* * *
Tu fu si contende con Li Po il titolo del più grande poeta cinese. Delle sue poesie, circa 1500, non esiste una edizione italiana. 34 poesie sono inserite nell’antologia Poesie di pace cinesi pubblicata da Guanda nel 1975, 38 nel volume collettivo Li Po, Tu Fu, Po Chu’i, Coppe di giada, edito dalla Utet nel 1985. Nessuno dei due libri è più in commercio. Così Due antichi poeti cinesi: Tao Yuan-Ming e Tu Fu di Sheiwiller, del 1988, che contiene 18 poesie. Parecchie delle poesie presenti nelle tre raccolte sono le stesse. Ciò vuol dire che in Italia possiamo leggere al massimo circa 50 sue poesie, a cercarne qualche raro esemplare nelle biblioteche.
“Per due anni ospite della
capitale dell’Est Ha sofferto problemi economici, spostamenti da una città a un’altra, disordini politici e rivolte, persino prigionia. Pare che notizie sulla vita di tutti i giorni come quelle che sono presenti nelle sue opere siano abbastanza rare nelle storie ufficiali del tempo. Leggo che in Cina è chiamato “il poeta santo” o “il poeta saggio”; che è stato uno sperimentatore di temi, metri e registri e che ciò lo ha reso un maestro in Cina e in Giappone.
|
|
COMPITO:
racconta la tua estate Appunti di viaggio: in Grecia di Giorgio Morale
(Milano 10 settembre 2006) |
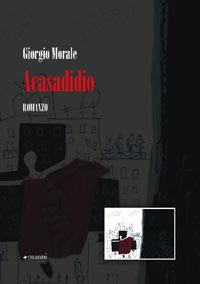 Giorgio Morale
Giorgio Morale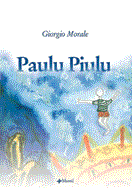
 Giorgio
Giorgio Innanzitutto le domande
Innanzitutto le domande
 Arriva
l’estate, la grande stagione, e ci disperde. Ci riprende la
nostalgia, per il nomadismo, per il mare.
Arriva
l’estate, la grande stagione, e ci disperde. Ci riprende la
nostalgia, per il nomadismo, per il mare. 